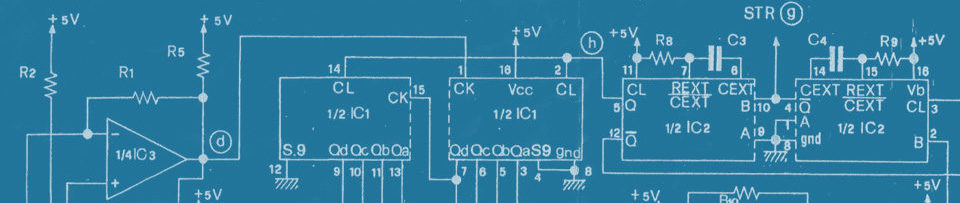Sezione “QUANDO”
Il lato sinistro di una regola, la sezione “QUANDO“, inizia con un blocco di un evento che può essere inserito dalla finestra di dialogo che appare quando viene selezionato selezioni il blocco vuoto più a sinistra di una regola:


presspressione del pulsante, icona micro:bit, o pin
releaserilascio del pulsante, icona micro:bit, o pin
movemovimento dell’accelerometro, in vari modi
hearsentire un suono, sia forte che soffuso
cambio di temperaturavariazione di temperatura, sia più calda che più fredda
ricezione radioricezione via radio di un numero
inizio paginainizia pagina si avvia solo quando la pagina viene avviata (o selezionata), con un ritardo opzionale
timertimer di un tempo


variabile (X,Y,Z)cambiato con un numero
Se la sezione “QUANDO” viene lasciata vuota, la regola verrà eseguita una sola volta quando la pagina viene avviata.
Eventi, parametri e condizioni
Un blocco evento può essere seguito:
- da nessun blocco;
- uno o più blocchi di parametro che determinano le condizioni sotto le quali l’esecuzione procederà dalla sezione “Quando” alla sezione “Fai”.
Ogni evento ha un parametro predefinito, che viene utilizzato quando non viene specificato alcun parametro. I valori predefiniti sono:
![]()
press, il valore predefinito del button A![]() ; altre opzioni includono
; altre opzioni includono button B ![]() ,
, micro:bit logo![]() ,
, pin 0 ![]() ,
, pin 1 ![]() ,
, pin 2 !![]()
![]()
release, i valori predefiniti e le opzioni sono gli stessi di press
La finestra di dialogo sottostante mostra i parametri associati agli eventi di press/release del pulsante.

In funzione dell’evento verranno mostrati parametri diversi.
Condizioni sui valori degli eventi
Quando un evento ha un valore numerico (nel caso della ricezione di un messaggio radio o di un aggiornamento di una variabile), se tale valore è uguale alla somma dei valori (costanti e variabili) che seguono, allora l’esecuzione proseguirà alla sezione “Fai”. Ecco i cinque valori (punti) disponibili:
1 dot:
2 dot:
3 dot:
4 dot:
5 dot:
Il timer è parametrizzato con vari tempi che possono anche essere sequenziati e sommati:
1/4 di secondo:
1 secondo:
5 secondi:
? secondi: – da 0 a 1 secondo, scelto casualmente
– da 0 a 1 secondo, scelto casualmente
Nel caso del timer, la somma specifica la quantità di tempo con cui avviare il timer.
Sezione “Fai”

Il lato destro di una regola, la sezione “Fai”, inizia con uno dei blocchi di comando presenti nella lista che segue:

show imagemostra una sequenza di animazione sullo schermo LED.
show numbermostra numero visualizza un valore numerico tra 0 e 99
sound emojiriproduce una sequenza di emoji
play notesriproduce una sequenza di note (dalla scala di Do maggiore)
radio sendinvia un numero dato tramite la radio
radio set groupprende un numero e garantisce che i messaggi radio da un diverso numero di gruppo vengano ignorati (il gruppo radio predefinito è 1, il che significa che tutti i micro:bit vedono tutti i messaggi)
switch pagetrasferisce il controllo dell’esecuzione a una pagina specifica
set variableinserisce un numero in una variabile (X, Y, Z); predefinito a 0 se non viene specificato nessun valore; inoltre imposta e
e 
Un comando può essere seguito da vari blocchi di parametro, a seconda del tipo di comando.


Come per gli eventi, ogni comando ha un parametro predefinito, nel caso in cui non venga dato alcun blocco di parametro i parametri predefiniti sono:

screenmostra di default una faccia felice
sound emojiriproduce di default l’emoji
giggle
radioinvia il numero 1 come predefinito
switchpassa di default alla pagina 1
getprende il valore da una variabile (X, Y, Z); se la variabile non era stata precedentemente impostata il valore predefinito è0. Ciò vale anche per e
e 
Buon Coding a tutti 🙂